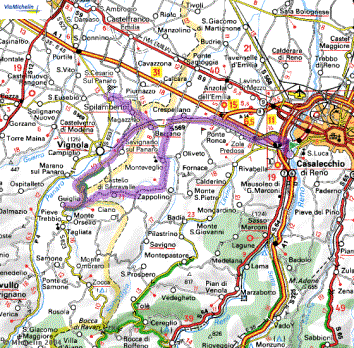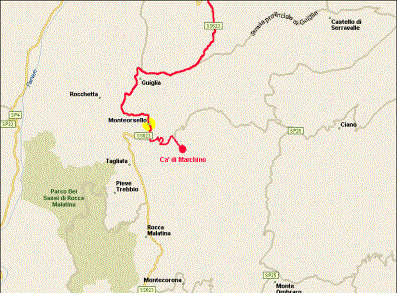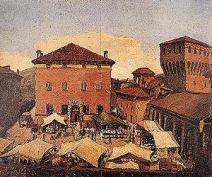|

|
Sabato/Domenica
13/14 Novembre
La via dei castelli bolognesi
Oggi sappiamo che la vita nei castelli non era
quella che ci immaginavamo nelle fiabe, ma i castelli continuano a mantenere
il loro fascino. Tina ci propone giro che ci porterà a riscoprire quel mondo
medioevale che ha costituito la ricchezza di questa regione, sempre in bilico
tra stato e chiesa, che mantiene le memorie della gesta del Duca Valentino e
quelle di Matilde di Canossa.
Lo andremo a vivere in un paio di giorni (il
turista tipo cercherebbe di fare in fretta tutto, in un giorno, ma noi
viviamo le cose in un altro modo)
|
Programma di massima
Mezzi
Auto, circa 470km’ il giro
Ritrovo alle 8.15 a Milano
Arrivo a Bazzano ore 10.30
Arrivo a Guiglia ore 18.00
Il resto si rifinisce secondo quanto preferito dal
gruppo
Rientro a Milano entro le 20.00 del 14/11
Spesa
prevista –
Trasferimento
Macchina circa 55 € a
macchina (compresa autostrada) in 4 persone son circa 14€ a persona
Mezza Pensione in
agriturismo cena del sabato,
pernottamento, prima colazione della domenica 38€ a testa
Pranzo del sabato e della
domenica, in libertà
|
|
Ma vediamo che cosa
ci propone Tina.
Da Bologna, dopo
Casalecchio di Reno, si percorre l'antica via Claudia detta anche
"Strada dei Castelli Medievali".
Ad un certo punto
appare alta e possente, la maestosa Rocca dei Bentivoglio nei pressi di
BAZZANO,borgo di remote origini.
Dopo la visita alla
rocca, per una stradetta minore si sale per 5 km a MONTEVEGLIO, piccolo borgo
che appare su un dirupato sperone roccioso e che domina la vallata del
torrente Samoggia.
Interessanti i
ruderi, la chiesa e l'abazzia di Santa Maria, di stile romanico.
Dopo l'anno mille, la
fortezza appartenne alla contessa Matilde di Canossa, ma subi' vari attacchi
nei secoli, dai longobardi ai lanzichenecchi...
Si prosegue per il
castello di Serravalle, con il suo piccolo e pittoresco centro storico,
posizionato su di un panormico poggio.
Le antiche mura che ancora
lo cingono, racchiudono, oltre che case medioevali, un palazzotto dell'epoca
delle Signorie, una chiesa trecentesca e i resti della possente Rocca.
Si prosegue per Guiglia, piccolo borgo, chiesetta e
rocca, ma non ho molte notizie in merito.
Vignola, oltre alle
celebri ciliege, ma ora non è stagione....si può vedere un bel castello
trecentesco in un grazioso borgo.
e da ultimo,
Spilamberto, con la famosa Rocca.
.
Riferimento Tina -
tina.a@iol.it
Oppure a Guido Platania
Tel 335/208784
- gp@helponline.it
|
|
 BAZZANO
– LA ROCCA DEI BENTIVOGLIO BAZZANO
– LA ROCCA DEI BENTIVOGLIO
ORARIO DI
APERTURA DELLA ROCCA
giovedì 15:30 - 19:00
sabato 15:30 -19:00
domenica 9:00 - 12:30 e 15:30 -19:00
Ingresso: €
1,50 comprensivi della visita al Museo Civico "Arsenio
Crespellani"
E' disponibile anche un servizio di visite
guidate alla Rocca bentivolesca e al Museo per gruppi di adulti, tutti i
giorni della settimana, esclusivamente su prenotazione.
Il costo della visita, che dura circa 2 ore è di € 70,00.
Le prenotazioni si effettuano al numero 339/7612628 (risponde una delle
guide).
Da fortezza
contesa…  Le origini della Rocca di Bazzano, a
dispetto della leggenda che la vuole costruita da Matilde di Canossa,
risalgono ad una data incerta ma sicuramente anteriore al Mille, nel
periodo in cui in tutta l'area padana sorgevano castella o castra in
difesa dalle invasioni barbariche. Nel 1038 il Vescovo di Modena Guiberto
concede in enfiteusi il castello e la chiesa di Santo Stefano al Marchese
Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, la quale lo riceverà in eredità
all'età di nove anni. Morta Matilde senza eredi il castello torna a
Modena. Le origini della Rocca di Bazzano, a
dispetto della leggenda che la vuole costruita da Matilde di Canossa,
risalgono ad una data incerta ma sicuramente anteriore al Mille, nel
periodo in cui in tutta l'area padana sorgevano castella o castra in
difesa dalle invasioni barbariche. Nel 1038 il Vescovo di Modena Guiberto
concede in enfiteusi il castello e la chiesa di Santo Stefano al Marchese
Bonifacio di Canossa, padre di Matilde, la quale lo riceverà in eredità
all'età di nove anni. Morta Matilde senza eredi il castello torna a
Modena.
Le prime
mura della fortezza vennero costruite nel 1218. Nel corso del Duecento la
Rocca  viene
assediata dai Bolognesi per ben due volte: nel 1228 con risultato
negativo e nel 1247, quando invece i Bolognesi riuscirono ad espugnarla,
pare per un tradimento, e diedero ordine di demolirla completamente
facendo trasportare le pietre a Monteveglio, dove furono utilizzate per
una casa torre destinata ai funzionari bolognesi di quel borgo. La
fortezza fu in seguito ricostruita da Azzo VIII d'Este tra il 1296 e il
1311. viene
assediata dai Bolognesi per ben due volte: nel 1228 con risultato
negativo e nel 1247, quando invece i Bolognesi riuscirono ad espugnarla,
pare per un tradimento, e diedero ordine di demolirla completamente
facendo trasportare le pietre a Monteveglio, dove furono utilizzate per
una casa torre destinata ai funzionari bolognesi di quel borgo. La
fortezza fu in seguito ricostruita da Azzo VIII d'Este tra il 1296 e il
1311.
Nel 1317 venne ricostruito anche il cassero posto sulla porta d'ingresso
delle mura, l'attuale torre dell'orologio. Dopo il 1371 i marchesi d'Este
ampliarono le mura della Rocca (la porta d'ingresso di queste nuove mura
è da identificarsi probabilmente con l'arco posto alcuni metri più in
basso del cassero scendendo verso il paese (l'ingresso sud, dal quale
passano le auto, risale invece a fine '800, quando venne costruito
l'attuale cimitero).
…a delizia
rinascimentale
L'aspetto attuale
dell'edificio risale però all'epoca rinascimentale, quando Giovanni II
Bentivoglio lo trasformò in "delizia" signorile destinata alle
vacanze in campagna. Dell'antico nucleo tardoduecentesco rimangono solo
la torre sul lato sud e l'ala attigua. Per il resto i nuovi muri a filari
alternati di laterizi e ciottoli vengono interamente intonacati e
parzialmente ricoperti di pitture, di cui sono conservate solo poche
tracce. Anche i merli a coda di rondine sono ridotti a puri motivi
decorativi.
Di notevole interesse quanto rimane delle pitture parietali delle sale,
in buona parte recentemente restaurate. Nelle sale a piano terra si
possono osservare alcuni stemmi a tempera, con gli emblemi dei
Bentivoglio (la sega rossa a sette denti) e della celebre dinastia
milanese degli Sforza (l'onda bianca e azzurra e il drago con un uomo in
bocca), che ricordano il matrimonio di Giovanni Bentivoglio con Ginevra
Sforza. Le iniziali Ms Zo rinviano allo stesso Giovanni Bentivoglio
("Messer Zoane").
La Sala dei Giganti, la maggiore della Rocca, presenta una
partitura architettonica di colonne, entro le quali sono inquadrati
paesaggi (forse raffiguranti Bazzano e altre terre dei Bentivoglio) e grandi
figure di armati con gli stemmi dipinti sugli scudi. Sul lato sud si
osserva sovrapposto un centauro meccanico di stile futurista, dei primi
del '900, tracciato al carboncino. L'adiacente Sala del Camino presenta
un motivo decorativo con l'arma bentivolesca inquartata con quella degli
Sforza racchiusa da una collana di perle entro una cornice quadrilobata a
nastro. Nella sala successiva (notare il soffitto) si osserva il frutto
dei restauri degli anni della prima parte del '900.
 La Sala dei
Ghepardi è decorata col motivo del ghepardo entro una cornice di
melograno, col motto "per amore tuto ben volgo soferire". La
Sala delle Ghirlande presenta lo stemma dei Bentivoglio inquartato con
quello primitivo degli Sforza (il leone rampante con un ramo di melograni,
o mele cotogne, su fondo blu); le iniziali di Giovanni Bentivoglio sono
qui alternate con quelle della moglie "Madonna Zinevra" (Ma Za;
a Ginevra alludono probabilmente i rami di ginepro). La Sala dei
Ghepardi è decorata col motivo del ghepardo entro una cornice di
melograno, col motto "per amore tuto ben volgo soferire". La
Sala delle Ghirlande presenta lo stemma dei Bentivoglio inquartato con
quello primitivo degli Sforza (il leone rampante con un ramo di melograni,
o mele cotogne, su fondo blu); le iniziali di Giovanni Bentivoglio sono
qui alternate con quelle della moglie "Madonna Zinevra" (Ma Za;
a Ginevra alludono probabilmente i rami di ginepro).
Gli ultimi
secoli
La Rocca divenne
successivamente sede del Capitanato della Montagna (notevoli i documenti
dell'Archivio dei Capitani e dei Vicari, conservati in Comune) e, nei
secoli seguenti, ospitò nei suoi ambienti le più svariate funzioni, da
carcere (dove fu rinchiuso nel giugno del 1799 il poeta Ugo Foscolo) a
teatro (nella Sala dei Giganti), da caserma a scuola, ad abitazioni
private (ancora fino agli anni '60). Oggi gli ambienti della Rocca
ospitano il locale Centro Musica (Mediateca Intercomunale) e il Museo
Civico "Arsenio Crespellani"; la Rocca è utilizzata per
svariati eventi pubblici e privati. Nella Cantina (ove sono visibili le
antichissime fondazioni del castello) è allestito il Punto informativo
dei prodotti della Strada dei Vini e dei Sapori "Città Castelli
Ciliegi".
|
|
IL MUSEO CRESPELLANI
ORARIO
DI APERTURA DEL MUSEO
giovedì
15:30 - 19:00
sabato 15:30 -19:00
domenica 9:00 - 12:30 e 15:30 -19:00
Ingresso € 1,50.
E' disponibile anche un servizio di visite guidate alla Rocca
bentivolesca e al Museo per gruppi di adulti, tutti i giorni della
settimana, esclusivamente su prenotazione.
Il costo della visita, che dura circa 2 ore è di € 70,00.
Le prenotazioni si effettuano al numero 339/7612628 (risponde una delle
guide).
 Il Museo, le cui origini vanno fatte
risalire alla nascita della Società archeologica bazzanese nel 1873, ospita (I SALA) materiali del
paleolitico, del neolitico (poderi Bellaria e Motta) e della media età del
bronzo (scavo Contu sulla collina della Rocca), a cui seguono reperti
dell'età del Ferro che testimoniano la fase villanoviana ed etrusca
(sepolcreto delle Fornaci Minelli). Il Museo, le cui origini vanno fatte
risalire alla nascita della Società archeologica bazzanese nel 1873, ospita (I SALA) materiali del
paleolitico, del neolitico (poderi Bellaria e Motta) e della media età del
bronzo (scavo Contu sulla collina della Rocca), a cui seguono reperti
dell'età del Ferro che testimoniano la fase villanoviana ed etrusca
(sepolcreto delle Fornaci Minelli).
Nella II SALA sono esposti materiali romani rinvenuti in gran parte nel
pozzo Sgolfo (Castello di Serravalle), oltre ad alcuni vetri e lucerne,
mentre nella III SALA si può ammirare il contenuto del pozzo Casini
(Bazzano). Si tratta di due casi di occultamento di beni all'interno di
pozzi in età tardoantica per difenderli da saccheggi e da incursioni. Da
rilevare due magnifiche brocche in bronzo dorato con manico finemente decorato
e una riga per misure lignea, resti animali e vegetali.
Tra i materiali sporadici romani rinvenuti sul territorio (elementi di
costruzioni ecc.) spicca una testa di dea (probabilmente Artemide) in marmo
greco. Nella sala vi sono inoltre alcuni materiali (principalmente
ceramica, inoltre ferri e vetri) di epoca tardomedievale e rinascimentale
rinvenuti nell'ambito della Rocca. La sezione risorgimentale e moderna
ospita armi e divise ottocentesche e novecentesche.
Il Museo Crespellani svolge un'intensa attività didattica per le scuole.
CHIESA DI SANTO STEFANO
|
 Se non si può escludere Se non si può escludere un’origine bizantina della chiesa,
essa è menzionata per la prima volta nel 789; all’edificio di questo
periodo risale probabilmente il reperto più antico attualmente
conservato, un probabile frammento del portale in pietra d’impronta
longobarda o carolingia. E’ invece conservato nella Rocca un capitello
attribuito al periodo romanico. un’origine bizantina della chiesa,
essa è menzionata per la prima volta nel 789; all’edificio di questo
periodo risale probabilmente il reperto più antico attualmente
conservato, un probabile frammento del portale in pietra d’impronta
longobarda o carolingia. E’ invece conservato nella Rocca un capitello
attribuito al periodo romanico.
L’attuale edificio è stato più e più volte modificato (la facciata è
stata ricostruita dopo i  bombardamenti dell’autunno ‘44). bombardamenti dell’autunno ‘44).
Originariamente la chiesa aveva un impianto a navata unica ed un
orientamento opposto a quello odierno, con l’abside collocata dove oggi
si trova l’entrata; tale assetto fu mutato nel corso dei secoli XVI e XVII
nell’ambito della ristrutturazione della complesso della Rocca. Il
campanile, recentemente restaurato, è del XVIII secolo.
 All’interno,
pregevoli opere quali il Santo Stefano di Simone Cantarini, all’altare;
alcune tele di Gaetano Gandolfi, che fu autore anche di alcune telle
della bella Via Crucis, opere di Crespi, di Alessandro Calvi e altri
autori (Morte di San Giuseppe; Santa Lucia) e una bella scultura lignea
raffigurante la Madonna della Pace. La chiesa è sede arcipretale. All’interno,
pregevoli opere quali il Santo Stefano di Simone Cantarini, all’altare;
alcune tele di Gaetano Gandolfi, che fu autore anche di alcune telle
della bella Via Crucis, opere di Crespi, di Alessandro Calvi e altri
autori (Morte di San Giuseppe; Santa Lucia) e una bella scultura lignea
raffigurante la Madonna della Pace. La chiesa è sede arcipretale.
|
|
|
MONTEVEGLIO
|
  Il
Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio tutela una significativa
porzione di territorio collinare che si estende a ridosso dell'abitato di
Monteveglio. Il
Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio tutela una significativa
porzione di territorio collinare che si estende a ridosso dell'abitato di
Monteveglio.
Nell'area protetta, delimitata a est e a ovest dal torrente Ghiaia di
Serravalle e dal rio Marzatore, si alternano paesaggi agricoli che
conservano gli assetti tradizionali della collina bolognese, ampie aree
calanchive di notevole interesse geologico e ripidi versanti boscati che
racchiudono piccole valli riparate di discreto valore naturalistico. La
storica abbazia di Monteveglio occupa il punto più elevato del bel borgo
medievale che si erge su uno dei rilievi principali del parco, inserendosi
nella trama di antichi nuclei fortificati e centri religiosi che
caratterizza la valle del Samoggia e quella vicina del Panaro.
Romani, Bizantini e Longobardi
Nella fertile fascia tra la pianura e la prima collina,
sui terrazzi fluviali di Samoggia e Panaro, l'insediamento romano dovette ben
presto fare seguito alla realizzazione della Via Emilia (187 a. C.) e alla
fondazione delle colonie di Modena e Bologna, anche se i reperti
suggeriscono un intenso popolamento sparso piuttosto che la presenza di un
vero e proprio agglomerato. Sulla base di questi ritrovamenti Crespellani
ipotizzò il tracciato di una strada, "l'antica strada Claudia alle
pendici dei colli modenesi e bolognesi", detta anche
"Predosa", che da Bologna attraverso Zola Predosa e Bazzano,
forse seguendo il percorso villanoviano, intercettava una direttrice per la
Toscana tra Samoggia e Panaro. Tutta la zona, divisa dal confine tra i
municipi di Modena e Bologna che correva lungo il Samoggia, venne
sicuramente interessata dall'espansione dell'agro centuriato molto al di
sotto della via Emilia. Nell'odierna viabilità se ne riscontrano ancora i
resti, in particolare un tratto residuo di cardo massimo che, con il
toponimo medievale di via Cassola, giunge fin sotto al colle di
Monteveglio. Si suppone che nel periodo romano e nel primo medioevo a
Monteveglio sorgesse il capoluogo di un importante "pago" esteso
tra Panaro e Samoggia e forse anche sulla riva destra di quest'ultimo verso
Oliveto. Gli scarsi reperti di epoca romana, restituiti soprattutto dal
torrente, suggeriscono l'esistenza di diverse villae lungo la vallata: una
statuetta in bronzo di Diana cacciatrice (conservata a Bologna), una testa
in marmo di dea (oggi a Bazzano), tombe romane e frammenti di anfore
vinarie. Anche nell'antico borgo sono presenti reperti romani: fregi
marmorei tra le pietre della facciata di un edificio, frammenti di colonne
di fianco a una porta, una lapide come mensa d'altare nella cripta della
chiesa di S. Maria. Durante il periodo bizantino Monteveglio fu dal secolo
VI una fortezza dell'Esarcato di Ravenna e insieme a Ferroniano, Persiceto,
Verabolo e Buxo (il podere Bucco vicino a Bazzano) fece parte della linea
difensiva lungo il confine con la Longobardia. Le prime notizie precise
risalgono a Paolo Diacono e Anastasio Bibliotecario, vissuti nel secolo IX,
che descrivono la Monteveglio bizantina come una città estesa e florida. Ma
già con l'invasione dei Longobardi di Liutprando, che la conquistarono nel
728, iniziò la decadenza: da città divenne un semplice castello che
mantenne comunque, anche dopo l'avvento dei Franchi, un importante ruolo
militare e amministrativo
Una terra di frontiera e di grandi battaglie
Quando Carlo Magno, occupati i territori longobardi, pose
i confini del suo regno intorno a Bazzano, la valle del Samoggia venne a
trovarsi nuovamente in una zona di frontiera. Tra i secoli IX e X, anche in
seguito alle invasioni ungare, nella valle vennero eretti nuovi castelli,
in parte sulle rovine di quelli bizantini (Monteveglio, Bazzano, Oliveto,
Serravalle, Zappolino, Savignano). A metà del secolo X buona parte della
vallata, dove aveva estesi possedimenti l'Abbazia di Nonantola, divenne
feudo dei Canossa: dei beni della contessa Matilde fecero parte Bazzano,
Monteveglio e le fortificazioni di Monte Morello e Monte Alfredo (oggi Monte
Freddo). Il cuore del parco fu teatro di un celebre episodio della lotta
per le investiture tra papato e impero, culminato nel 1092 con l'assedio
del castello di Monteveglio, che resistette vittoriosamente e, con una
felice sortita dal vicino colle della Cucherla, inflisse una dura sconfitta
all'esercito di Enrico IV (che vi perdette il figlio). Dopo la vittoria
Matilde consolidò e accrebbe con beni il castello e la pieve, concedendo ai
sudditi particolari privilegi. Dopo la sua morte si manifestarono i primi
segni della ripresa cittadina e Monteveglio divenne libero comune,
alleandosi alternativamente con Modena e con Bologna nelle interminabili
lotte tra le due città. La battaglia più celebre si svolse nel 1325 presso
il castello di Zappolino, nei prati di Saletto e Parviano, e i Modenesi,
con un forte esercito ghibellino, compirono una vera strage tra i Bolognesi
(fu la battaglia che ispirò a Tassoni "La secchia rapita").
Questo destino guerriero si protrasse per secoli, in un succedersi di scontri
e battaglie, culminando nel celebre tentativo di conquista di Monteveglio
da parte dei Lanzichenecchi, al seguito delle milizie imperiali di Carlo V,
che nel 1527 posero l'assedio al castello; la leggenda narra che
un'improvvisa e imponente nevicata li costrinse a desistere (in ricordo
ogni anno si tiene una processione votiva).
|
|
|
IL CASTELLO DI SERRAVALLE
|
Un po’ di storia:
Dopo
la caduta dell’esarcato di Ravenna che aveva autorità sul territorio del
Samoggia, le comunità che abitano nella valle si ergono a comuni autonomi.
Nascono i castelli di Zappolino, di Tiola, di Cuzzano e altri.
E
nasce Serravalle come borgo franco (1227), strumento di vitale importanza
nel controllo di un vasto territorio. Il “castrum Seravalis” figura
fra le proprietà dell’abbazia di Nonantola fino al 1229, mentre, in
seguito, si ha la giurisdizione della Judiciaria di Monteveglio. Un
bassorilievo fa risalire al 1235 la prima data sicura del possesso
bolognese, con l’insediamento del primo capitano della montagna: Jacopino
da San Lorenzo in collina.
Che
Serravalle svolga un ruolo importante nell’economia di queste zone di
confine lo testimoniano, oltre alle ruberie, alle rapine e alle discordie
intestine fra le comunità dei singoli castelli, anche le tante scaramucce
fra bolognesi e modenesi per il possesso di questo territorio.
Col
passare degli anni il castello di Serravalle acquista sempre più importanza
per la sua posizione strategica a cavallo fra le vallate del Panaro e del
Samoggia.
Il
presidio bolognese si trova così a controllare due versanti: una sentinella
“cara” quanto indispensabile: una sentinella a guardia di due mondi, di due
culture, di due ambienti geografici differenti.
I
rapporti fra Bologna e Modena peggiorano fino allo scontro di Zappolino
(1325) ma la zona passerà ancora per molte mani: sarà proprietà dei
Visconti, poi dei Bentivoglio, dello Stato della Chiesa e di altri ancora.
I
castelli, mano a mano che matura la politica territoriale e quella delle
armi da fuoco, si riducono a semplici ricordi storici quando addirittura
non scompaiono.
Di
quello che è stato uno dei più popolati castelli del Medioevo (nel 1303 si
contano ben 91 fumanti, vale a dire unità familiari di tassazione) oggi
rimangono imponenti tracce nella sola porta castellana del cassero turrito
inserita nella cinta delle mura.
Nessuna
traccia dei mezzi baluardi che fiancheggiano le mura, nessuna del grande
fossato attraversato dal ponte levatoio.
La
rocca a pianta romboidale risale al XVI secolo e sorge sulle rovine di
quella abbattuta per ordine del Senato nel 1451: all’interno è ancora
visibile un avanzo della vecchia struttura: un muro ed una porta in pietre
ed una porta in pietre di forma parallelepipeda.
Altri
interventi e manomissioni non sono tuttavia riusciti a scalfire l’unicità
di un’atmosfera che, varcata la porta castellana consegna a sensazioni
molto profonde: quella che doveva essere la vita in un borgo fortificato
medievale ci ricorda qualcosa che assomiglia al “Deserto dei Tartari”. Ma i
Tartari, presenze concrete, portano il nome di “Ghibellini”.
Ancora
nel 1796 la Rocca ospitava una fornita armeria per armare 40 uomini.
Serravalle,
Zappolino e Tiola verranno riunite durante l’epoca napoleonica (1815) e la
sede comunale verrà trasferita a Castelletto, allora piccola borgata di
poche case poste al centro di questo territorio.
Nel
1861 Castello di Serravalle entra a far parte del regno d’Italia e
successivamente partecipa alle vicende politiche e sociali dello Stato
Italiano.
I
suoi abitanti partecipano ad entrambe le due guerre mondiali; numerosi sono
i caduti e importante è il contributo dato alla Resistenza e alla
ricostruzione nel dopoguerra.
|
|
I SENTIERI E LE PASSEGGIATE
A piedi o a cavallo, si possono scoprire gli
angoli più belli del territorio di Castello di Serravalle.
Una rete di
sentieri e stradine di campagna, contrassegnata con i classici segnavia
bianchi e rossi del C.A.I., si sponda tra le colline, i vigneti, i calanchi
e i piccoli borghi.
Tre sono gli
itinerari più importanti:
1.
Il classico “Sentieri dei Calanchi”
che parte da Castelletto e forma un grande anello entrando al centro
dell’anfiteatro calanchivo di Tiola e Maiola. Il tratto Castelletto – Zara
– Maiola- Tiola può essere comodamente percorso in circa 3 ore.
2.
La “Via Longobarda” così chiamata
perché ripercorre l’antico tracciato che collegava Nonantola alla Toscana e
a Roma passando anche per la Valle del Samoggia: provenendo da Monteveglio
si passa nei pressi di Serravalle, di S. Apollinare, Montalogno e Tiola.
L’intero tragitto Monteveglio – Tiola si percorre in circa 5 ore.
3.
Il “Sentiero Samoggia”, un
percorso naturalistico che costeggia il torrente omonimo da Calcara (Crespellano)
fino a Savigno passando da Fagnano e Ponzano. Il tratto Fagnano – Ponzano
si snoda quasi interamente nel bosco ripariale e si percorre in circa 1
ora.
|
|
|
GUIGLIA
|
L'antico Castello di
Guiglia, distrutto da un violento incendio nel 1361 venne ricostruito in
circa quarant'anni, e completato verso la fine del XIV secolo. A tale
fase è ascrivibile la torre attuale e l'ala orientale del castello, un
tempo munita di ponte levatoio. Danneggiato dal terremoto del 1571, fu
successivamente oggetto di saccheggi fino a quando, nel 1630, il Marchese
Francesco Montecuccoli iniziò lavori di radicale trasformazione
dell'antica rocca in sontuosa residenza nobiliare della sua famiglia. In
tale occasione fu rimosso il ponte levatoio e chiusa la vecchia porta a
oriente, furono ampliati gli appartamenti e creato un nuovo e prestigioso
accesso, l'attuale, costituito da un alto portale sormontato da un
timpano sostenuto da colonne attraverso il quale si accede ad una loggia
decorata da pregevoli stucchi. All'interno delle mura esisteva anche un
convento di Carmelitani, con l'annessa chiesa. Alla fine dell''800 il
castello fu messo all'asta perché gli eredi dei Montecuccoli non pagavano
le tasse e in seguito fu trasformato in albergo. Il pregevole complesso,
dopo travagliate vicende, è infine divenuto di proprietà comunale.
La torre del
Pubblico, collocata davanti all'originario ingresso della rocca,
(risalente presumibilmente da una data letta dallo storico Giannotti
all'anno 1535), ha pianta quadrata, portale in cotto ad arco a strombo ed
è sormontata dalla cella campanaria arretrata dotata di campana
seicentesca. L'edificio attiguo sembra fosse la Casella in cui si
svolgevano le adunanze della Comunità.
Nei pressi del
Castello sorge l'Oratorio della Madonnina che fu fatto costruire alla
fine del XVII secolo da Ottavia Caprara, vedova del marchese Giambattista
Montecuccoli, per ospitare un'immagine dipinta su carta della Beata
Vergine di San Luca, precedentemente collocata su un pilastrino posto
presso la ripa del Campo superiore ed alla quale erano attribuiti
numerosi miracoli. La costruzione fu terminata dal figlio Raimondo nel
1715 e pochi anni dopo vi fu traslata l'immagine.
Il corpo interno
dell'oratorio consiste in tre nicchie con unico altare collocato in
quella di mezzo. Ripostiglio e sagrestia sono ai lati dell'ingresso.
La cupola è
sormontata da una lanterna circolare. Anche il tamburo è a pianta
circolare ed è affiancato da un campaniletto a vela. Il portale, con
profilo superiore semiottagonale, è sottolineato da una cornice modanata
in terracotta.
All'interno
conserva tre tombe dei marchesi Montecuccoli Laderchi e numerosi ex voto
di fattura popolare.

|
|
Dopo essersi
sottomessi agli Estensi, i signori di Guiglia iniziarono, nel 1362, la
costruzione di un nuovo castello. Nel 1630 il duca Francesco I d'Este infeudò
Guiglia ai Montecuccoli che trasformarono la rocca in sontuoso palazzo
signorile, inoltre fece iniziare la costruzione di un convento per gli
Scolopi, dotandolo di ricchi possedimenti, con l'onere di educare la
gioventù. La famiglia dei Montecuccoli conservò il dominio fino alla fine del
secolo XVIII, quando fu abolito il sistema feudale. Il complesso è circondato
da un parco.
Accessibilità:
visitabile internamente
|
|
La Rocca di Vignola e la sua storia
Il profilo della
città di Vignola si identifica con la sua celebre Rocca, uno degli esempi più
interessanti di architettura fortificata della Regione.
Citata già nel secolo IX, la tradizione la vuole fondata da Sant'Anselmo
abate di Nonantola, come presidio a difesa dei territori dell'Abbazia.
Soggetta nel X secolo al Vescovo di Modena, la Rocca passò successivamente al
Comune di Modena sotto la cui giurisdizione rimase fino al 1227, per passare
ai Grassoni che la tennero fino alla fine del 1300 quando gli Estensi la
infeudarono alla famiglia Contrari di Ferrara, nella persona di Uguccione
(1401).
Sorta come struttura difensiva (all'epoca dei Grassoni alla
preesistente torre Nonantolana furono aggiunte tre torri merlate denominate
rispettivamente "delle Donne", "del Pennello" e
"dell'Orologio"), con la signoria dei Contrari la Rocca fu
trasformata in sontuosa dimora ricca di decorazioni ed affreschi sul modello
delle dimore estensi ferraresi.
Estinta la dinastia dei Contrari con l'assassinio di Ercole,la Rocca fu
acquistata nel 1577 dalla famiglia Boncompagni che conservò la signoria sino
al 1796, quando, a seguito della conquista napoleonica, Vignola divenne
capoluogo di Cantone del Dipartimento del Panaro.
Nel corso dell'800 la Rocca ospitò, sparsi tra i vari piani, gli uffici
comunali, la biblioteca e i primi locali della nascente Cassa di Risparmio,
che nel 1965 ha acquisito la proprietà del Castello per poi cederla nel 1998
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, che oggi provvede alla
migliore gestione e valorizzazione della Rocca, anche organizzando nelle sue
sale eventi culturali di notevole interesse.
Le Sale della Rocca derivano i loro nomi dai motivi ricorrenti raffigurati
negli affreschi, tutti risalenti alla prima metà del XV secolo, all'epoca
della signoria dei Contrari.
Al pianterreno: Sala dei Leoni e dei Leopardi; Sala delle colombe; Sala Degli
anelli.
Al piano superiore o Nobile: Cappella decorata con un prezioso ciclo di
affreschi tardo-gotici; Sala delle Dame; Sala del Padiglione; Sala degli
Stemmi; Sala dei Tronchi d'albero.
Dopo la salita al cassero, dal quale si gode una splendida vista sulla piazza
antistante la Rocca dominata da Palazzo Boncompagni e sull'antico borgo di
Castelvecchio, è possibile visitare gli alloggi degli armigeri, poi
trasformati in prigioni, e i camminamenti di ronda che collegano tra loro le
torri. Nei sotterranei si trova la suggestiva Sala dei Contrari, oggi
utilizzata per convegni, conferenze e concerti.
Costruito nella parte bassa della torre di guardia alla Rocca, l'Oratorio di
Santa Maria fuori Porta Posterla contiene affreschi venuti alla luce in
seguito ai restauri del 1976 ed un tondo in gesso dorato con l'immagine della
Madonna col Bambino ora trasferito nella Rocca e sostituito con un calco in
gesso.
Palazzo Boncompagni (o Palazzo Barozzi)
Sorge su un lato
della piazza dei Contrari antistante la Rocca e fu realizzato intorno al
1566-67, per volere di Ercole Contrari, dall'architetto ferrarese Bartolomeo
Tristano, all'epoca operante per il duca di Modena Alfonso II.
Edificato su progetto del noto architetto vignolese Jacopo Barozzi,
l'edificio consta di un corpo centrale e due laterali, con portale a bugnato.
All'interno si può ammirare la scala a chiocciola a pianta ovale
costruita da Bartolomeo Tristano sempre su disegno del Barozzi.
Passato ai Boncompagni, dopo essere stato trascurato per molto tempo, nel
1880 per volere del principe Antonio Boncompagni Ludovisi fu affrescato dai
pittori modenesi Fermo Forti e Angelo Forghieri.
In facciata si trova la targa in bronzo con l'effigie dell'architetto Iacopo
Barozzi detto "il Vignola", opera dello scultore savignanese
Giuseppe Graziosi. (1905 ca.)
Di proprietà della Parrocchia di Vignola, è sede del Circolo ACLI
Chiesa Parrocchiale dei SS.Nazario e Celso
In origine costruita nelle immediate vicinanze del Castello è menzionata
ufficialmente per la prima volta in un documento del 1299 assieme alla chiesa
di San Martino in Centoripe. All'epoca di Uguccione dei Contrari la chiesa fu
ricostruita ed ampliata entro le mura del castello. Nel 1680 fu ampliata e
ricostruita in stile corinzio su disegno di Zaccaria Pellini. Innalzato il
corpo centrale della chiesa, il braccio trasversale della croce latina, il
presbiterio e il coro rimasero incompiuti a causa di dissensi interni alla
comunità parrocchiale. I lavori di completamento ripresero solo a partire dal
1792 quando la direzione dei lavori fu affidata al Toschi, che ridusse
l'originario progetto del Pellini: nel braccio sinistro della croce latina
venne costruita la sagrestia con accanto il presbiterio, mentre il coro venne
adattato in uno spazio piuttosto angusto dietro l'altare maggiore. Nel 1841
l'architetto Cesare Costa venne incaricato dell'ampliamento della chiesa
ridotta a forma basilicale: furono abbattuti il vecchio coro e la sagrestia.
L'ultimo intervento in ordine di tempo risale al 1889 quando, sotto la
direzione dell'architetto Carlo Barberi, fu completata la facciata in stile
classico con colonnati e capitelli corinzi. Nel 1890 alla sommità del
campanile fu collocata una cuspide per consentire alla chiesa di imporsi
maggiormente nel contesto urbano. Oggi la chiesa si mostra in tutta la sua
imponente facciata di ordine gigante, sormontata da un frontone con
decorazioni a cornice. Nell'interno a tre navate si conservano dipinti di
Elisabetta Sirani, Francesco Stringa e Adeodato Malatesta e una Pietà in
bronzo dorato dello scultore vignolese Ivo Soli.
Santuario della Madonna della Pieve
Alla periferia della
città, a lato della strada per Marano sul Panaro, si trova l'antica chiesa
che la tradizione vuole eretta all'epoca di Liutprando, re dei Longobardi,
sulle fondamenta di un tempio pagano. Fu intitolata a San Martino: da
documenti d'epoca si rinviene infatti la denominazione di un San Martino in
centum ripis, a causa del dissesto orografico ed idrografico del luogo.
La prima menzione certa della chiesa, tuttavia, compare in un documento del
1174: ubicata presso i confini di Campiglio, sorgeva ai piedi dei colli con
la facciata sulla via Claudia che da Savignano volgeva verso il Panaro.
Crollata quasi completamente nel 1400, sulle sue rovine nel 1665 fu
eretto un oratorio che conservò dell'antica pieve romanica solo le absidi
superstiti.
Nel tempietto, dedicato alla Beata Vergine della Pieve, fu collocata una
statua che si suppone risalga al XIII secolo raffigurante la Madonna in trono
col Bambino, ancora oggetto di grande venerazione.
L'attuale edificio conserva l'aspetto seicentesco: è preceduto da un portico,
è dotato di un piccolo campanile sul tetto e lateralmente si innesta ad un
fabbricato adibito a canonica.
Soltanto la parte absidale, con volta a sesto acuto, e gli attacchi delle
arcate, con semicolonne in cotto e capitelli svasati, fanno parte della
costruzione primitiva.
Murati nell'abside di mezzo si vedono due frammenti in pietra con rilievi a
treccia, testimonianze di un più antico edificio.
Le tradizionali funzioni che si celebrano il primo sabato di maggio e l'8
settembre testimoniano il forte legame, ancora oggi esistente, tra l'antica
Pieve e la popolazione vignolese.
Chiesa di Santa Maria in Tortiliano detta "La Rotonda"
Ubicata sul Poggio Ericino, la Chiesa di Santa Maria in Tortiliano così
citata in un documento dell'826, fu riedificata completamente nel 1491 per
volere del nobile vignolese Bartolomeo Moreni, secondo i modelli
architettonici rinascimentali diffusi in area lombarda.
Il tempietto ha rigorosa pianta circolare ed appare formato da due cilindri
sovrapposti.
L'interno, circolare, si articola in modo armonico su otto nicchioni scavati
nella muratura del primo ordine del tamburo coperto da una cupola
emisferica.La derivazione da invenzioni bramantesche, diffuse in Lombardia e
accolte in Emilia proprio alla fine del Quattrocento, resta evidente nella
calibrata euritmia dei volumi interni e nella sobria compattezza dell'insieme.
All'interno si trovano un affresco con la Madonna in trono con il Bambino e
donatori ed un paliotto in scagliola del XVIII secolo con decorazione a
racemi che delimitano lo scudo gentilizio della famiglia Moreni. La Chiesa è
oggi di proprietà privata.
Villa Tosi-Bellucci
Sede comunale dal 1916, l'antica proprietà dei Bellucci modificata ai primi
dell'Ottocento su disegno dell'architetto vignolese Giuseppe Maria Soli, si
presenta oggi con un corpo centrale quadrato di gusto neoclassico e due corpi
laterali aggiunti in un periodo successivo.
All'interno è possibile ammirare gli affreschi del pittore vignolese Pietro
Minghelli.
All'esterno, collocato al centro del giardino il Monumento ai Caduti
della Prima Guerra Mondiale, opera dello scultore vignolese Luigi Bondioli.
Villa Braglia
Presenta la tipica struttura della residenza della borghesia agraria
emiliana: un imponente edificio decorato sull'esterno con motivi a
candelabre.
L'interno ed il giardino, ora scomparso, furono progettati dallo scenografo
modenese Andrea Becchi.
Torre Galvani e giardino pensile
Delle quattro torri inserite nella cerchia delle mura e che prendevano
il nome dalle famiglie che ne avevano la custodia (la "Fontana" o
del Cannone, la "Moreni", la "Galvani", e la
"Emiliani") resta soltanto la torre dei Galvani, con il
caratteristico galletto segnavento.
La torre fa parte di uno degli itinerari delle "Case Torri", tra le
quali si segnala la Torre del Sale in località Tavernelle.
Dalla strada è possibile intravedere il giardino pensile, realizzato nel XV
secolo dalla famiglia Galvani sulla cinta muraria e trasformato ai primi
dell'Ottocento in un raffinato giardino neoclassico, un "unicum"
nel panorama dei giardini emiliani.
Da segnalare la Villa dei Galvani, d'epoca neoclassica, decorata al
suo interno con affreschi di Pietro Minghelli, residenza di villeggiatura e
cenacolo culturale dei conti vignolesi. La Torre, la villa e il giardino sono
attualmente di proprietà privata.
Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori
La casa dove il 21 ottobre 1672 nacque Ludovico Antonio Muratori, è situata
nel centro storico di Vignola su via Selmi al nr. 2. Di aspetto modesto, la
costruzione consta di due piani ed un portico laterale. All'interno è stato
riaperto al pubblico, dopo un accurato restauro, lo "studiolo" del
Muratori, con gli arredi dell'epoca.
Il piano terreno è adibito a spazio espositivo, denominato "Salotto
Ludovico Antonio Muratori" ed ospita, da settembre a giugno e con
cadenza quindicinale, mostre personali e collettive di artisti provenienti da
tutta Italia, organizzate dall'Associazione culturale "Amici
dell'Arte" di Vignola.
Orario di apertura: giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 19.00; giorni
festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; lunedì
chiuso.
|


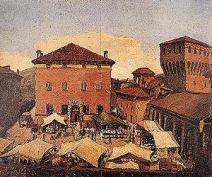







|